di Andrea Striano
Responsabile Dipartimento Imprese & Mondi Produttivi – Fratelli d’Italia, Caserta
Nell’immaginario collettivo, “piccola impresa” è sinonimo di fragilità. L’idea di una dimensione ridotta, familiare, quasi artigianale, rimanda spesso a una struttura vulnerabile, incapace di reggere la competizione globale. Eppure, l’economia reale racconta una storia diversa: sono proprio le piccole e medie imprese a costituire l’ossatura produttiva dell’Italia. Il 92% delle imprese italiane ha meno di dieci addetti e, insieme, genera oltre il 60% del valore aggiunto nazionale. È una forza silenziosa, distribuita in ogni provincia, capace di mantenere viva la manifattura, presidiare i territori e creare occupazione stabile anche nei momenti di crisi.
La loro solidità non deriva dalla dimensione, ma dalla capacità di adattarsi. Nella flessibilità, nell’intuizione e nella rapidità decisionale risiede il vero vantaggio competitivo delle piccole imprese italiane. Dove le grandi strutture necessitano di procedure complesse, le piccole possono reagire quasi in tempo reale alle variazioni della domanda, ai mutamenti del mercato, o alle nuove esigenze dei clienti. È un modello di impresa che privilegia la concretezza: sperimentare, rischiare, innovare. Questo approccio non è improvvisazione, ma metodo. È una forma di organizzazione agile che consente di ottimizzare risorse, valorizzare il capitale umano e mantenere una filiera corta ma altamente efficiente.
Durante le fasi di crisi economica, la forza delle micro e piccole imprese è emersa in modo evidente. Nel periodo post-pandemico, mentre molte realtà internazionali hanno ridotto la loro presenza produttiva o delocalizzato, la maggior parte delle PMI italiane ha scelto di restare sul territorio, reinventando prodotti e processi. Secondo Unioncamere, tra il 2020 e il 2023 oltre il 70% delle imprese che avevano investito in digitalizzazione, efficientamento energetico o diversificazione commerciale ha registrato un incremento del fatturato. Si tratta di una “resilienza strutturale” che ha radici profonde nella cultura industriale del Paese: la capacità di trasformare ogni vincolo in un’opportunità e ogni crisi in un’occasione di ripensamento strategico.
Ma questa forza naturale rischia di non bastare più. Le piccole imprese si trovano oggi di fronte a ostacoli sistemici che ne limitano il potenziale: accesso al credito, burocrazia, mancanza di strumenti di internazionalizzazione. L’accesso ai finanziamenti rimane il nodo più critico. Secondo la Banca d’Italia, nel 2024 solo una richiesta su due proveniente da microimprese è stata accolta positivamente. Non per mancanza di solidità, ma per l’assenza di garanzie formali o di rating bancari adeguati. Questo penalizza proprio le realtà più dinamiche, quelle che vogliono investire in innovazione, in macchinari, in capitale umano. La conseguenza è che molti progetti restano sulla carta, soffocati da regole pensate per imprese di altra scala. Un paradosso inaccettabile in un Paese che fonda la sua economia su oltre quattro milioni di PMI.
A questa criticità si aggiunge la questione della semplificazione amministrativa. Negli ultimi anni si è molto parlato di riduzione degli oneri burocratici, ma la distanza tra gli annunci e la realtà quotidiana rimane enorme. Ogni adempimento comporta tempi e costi che sottraggono energie alla produzione. Secondo Confartigianato, il peso burocratico medio per una microimpresa supera i settemila euro annui, senza contare le ore di lavoro impiegate nella compilazione di moduli o nell’interpretazione di norme in continua evoluzione. È un costo invisibile che mina la competitività, soprattutto per chi non dispone di uffici amministrativi interni o consulenze continuative. In molti casi, l’imprenditore italiano si trova a dover scegliere se dedicare tempo all’innovazione o alla burocrazia: una scelta che non dovrebbe nemmeno esistere.
Eppure, nonostante questi limiti, le piccole imprese italiane continuano a essere protagoniste sui mercati esteri. Nel 2024 le PMI hanno contribuito a oltre la metà del valore totale delle esportazioni italiane, confermando che la qualità, la creatività e l’affidabilità del Made in Italy restano riconosciute in tutto il mondo. I distretti produttivi – dalla meccanica di Brescia al tessile di Prato, dall’oreficeria di Vicenza e Marcianise all’agroalimentare campano e pugliese – continuano a essere laboratori di eccellenza e modelli di cooperazione territoriale. Dove esiste una rete, cresce la competitività. Le aggregazioni di imprese, i consorzi per l’export e i partenariati locali sono la chiave per affrontare mercati sempre più complessi, condividendo strategie, competenze e infrastrutture.
In questo scenario, il concetto di “intelligenza artigiana” assume un valore centrale. È la capacità di unire conoscenza pratica e visione strategica, di adattare il sapere tradizionale ai nuovi strumenti tecnologici senza perdere l’anima produttiva. L’Italia possiede una cultura del fare che il mondo intero ci riconosce, ma che va sostenuta e attualizzata. La transizione digitale, la sostenibilità e l’innovazione non devono essere percepite come imposizioni esterne, ma come strumenti per rafforzare la competitività delle imprese. Il vero salto culturale non è solo tecnologico, ma organizzativo: imparare a comunicare, a collaborare, a raccontare il proprio valore in modo strutturato. Perché la reputazione oggi è parte integrante del capitale d’impresa.
Dietro ogni piccola impresa c’è una storia di sacrificio, di competenza e di responsabilità sociale. Sono realtà che generano occupazione, formazione, e spesso coesione territoriale. Quando un laboratorio chiude, non si perde solo un posto di lavoro, ma un pezzo di comunità. Quando un’impresa resiste, invece, mantiene viva la dignità del lavoro e il senso di appartenenza. In molti territori, le PMI sono l’unico presidio economico rimasto, un punto di equilibrio tra economia e società. È per questo che sostenere le piccole imprese non è un tema corporativo, ma una scelta di politica industriale e civile.
L’Italia non potrà crescere senza rimettere al centro chi produce. Non servono slogan, ma strumenti: credito accessibile, procedure snelle, incentivi all’export, percorsi di formazione e consulenza diffusi. Le piccole imprese non chiedono assistenza, ma condizioni per competere ad armi pari. Il resto lo sanno già fare: progettare, produrre, innovare, resistere. In fondo, la loro forza è la stessa del Paese che rappresentano: concreta, ingegnosa, testarda, profondamente italiana. E se oggi l’Italia tiene, è perché ogni giorno milioni di imprenditori, silenziosamente, continuano a farla funzionare.
SOCIAL
CONTATTACI
INDIRIZZO
SOCIAL

Via Nizza, 53 – 00198, Roma
Via Nomentana, 56 - 00161 Roma
© copyright 2023 | C.F. 96568340580 | All Rights Reserved.
Le piccole imprese italiane che tengono in piedi l’economia: il motore invisibile del Paese
Le piccole imprese italiane che tengono in piedi l’economia: il motore invisibile del Paese
2025-10-06 08:53
2025-10-06 08:53
Array( [86865] => Array ( [author_name] => Emidio SIlenzi [author_description] => [slug] => emidio-silenzi ) [87630] => Array ( [author_name] => Andrea Striano [author_description] => [slug] => andrea-striano ) [89101] => Array ( [author_name] => Antonino Castorina [author_description] => [slug] => antonino-castorina ) [89102] => Array ( [author_name] => Marco Bourelly [author_description] => [slug] => marco-bourelly ) [89825] => Array ( [author_name] => Antonio Grieci [author_description] => [slug] => antonio-grieci )) no author 86807
PMI, imprese, economia, pmi, andrea-striano,

di Andrea Striano

Tecnologie e capitale umano: il futuro competitivo delle imprese
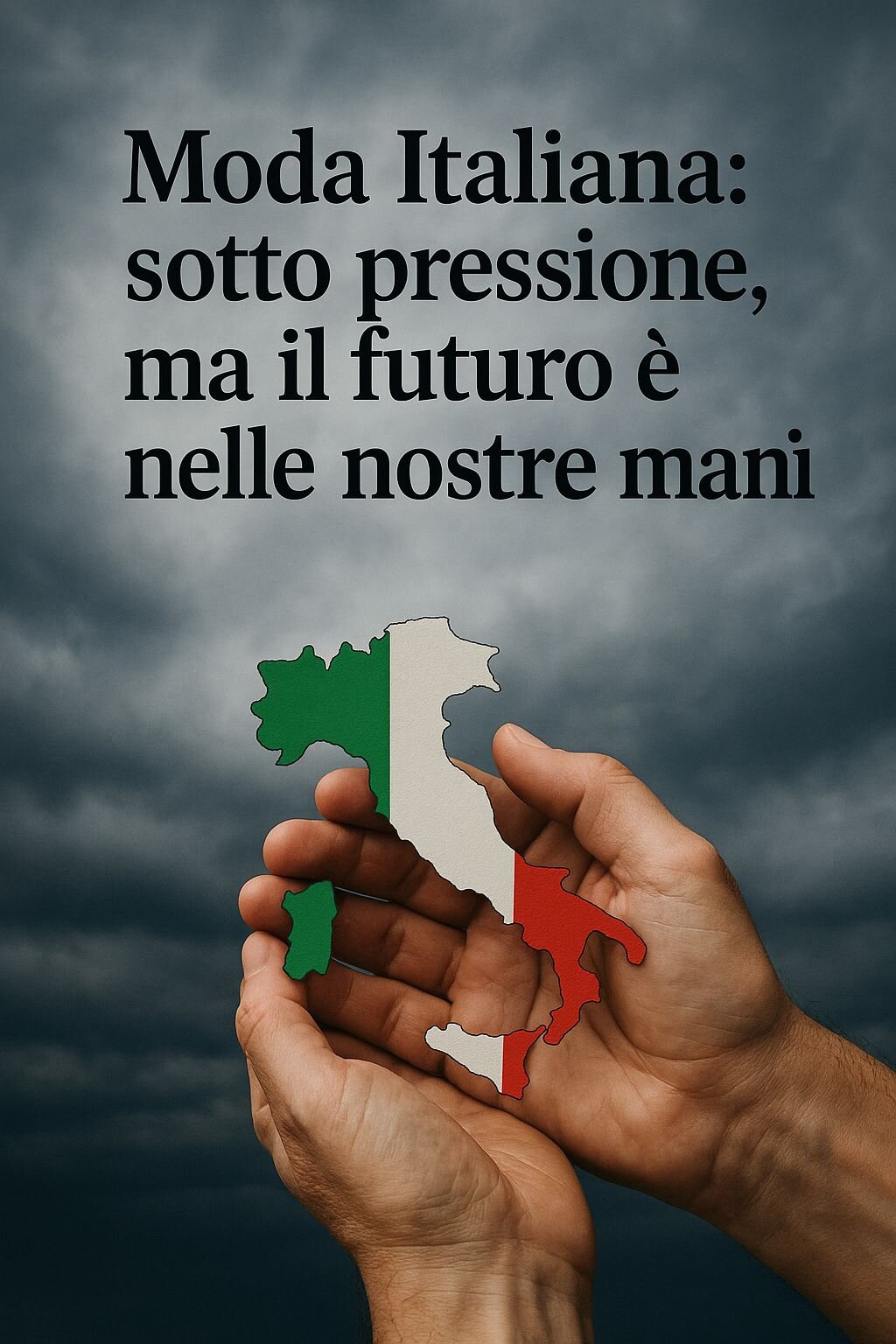
Moda Italiana: Il Made in Italy sotto pressione, ma il futuro è nelle nostre mani

Dazi USA e l’Europa davanti allo specchio Un’opportunità politica e culturale sotto pressione commerciale

