di Romano Benini
Il principale tesoro italiano è costituito dal patrimonio di capacità e saper fare accumulato nei secoli e che ancora oggi costituisce la base delle produzioni di eccellenza del Made in Italy. E’ interessante notare come, soprattutto nel secondo dopoguerra, lo sviluppo dell’industria manifatturiera abbia portato anche in Italia alla produzione di beni e prodotti di largo consumo e a basso valore aggiunto, ma come questo tipo di produzione si sia aggiunta alle produzioni della tradizione e dell’identità storica italiana senza con questo sostituirle, se non in minima parte. Con la crisi dell’industria “fordista” l’economia italiana ha ridotto il ruolo della produzione industriale di prodotti di massa a basso valore aggiunto ed ha aumentato, da un lato, il ruolo delle produzioni di qualità basate sui saperi diffusi delle vocazioni territoriali, che aggiornano i settori produttivi dell’identità tradizionale italiana e, dall’altro, la funzione della produzione manifatturiera di qualità, aggiornata in questo caso attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie ed un abile uso di una conoscenza moderna, che sviluppa un sapere antico e molto italian, ossia il design.
L’impresa diffusa è in Italia il settore costituito soprattutto dalle reti di piccola e media impresa e delle imprese artigiane, che costituiscono più del 90% delle imprese italiane e che determinano più del 50% delle esportazioni e quasi il 70% dell’occupazione. Il valore aggiunto di questo sistema di imprese equivale ai due terzi dell’industria tedesca ed è superiore a quello di tutte le industrie francesi od inglesi. Si tratta di giacimenti culturali, ancora prima che di settori di impresa. Di saperi che danno un senso, perché carichi di significato, che non va visto solo come un risultato economico, ma come benessere complessivo generato dalla relazione tra il risultato economico, sociale e culturale. Sono saperi che vengono dal territorio e che portano con sé l’identità delle comunità a cui appartengono: in molti casi sono conoscenze così radicate nella storia che è difficile trasferirle altrove. L’Italia delle diversità culturali e dei mille dialetti, dei tanti paesaggi e culture, ha infatti creato quelle vocazioni produttive che oggi si trasformano in distretti e reti. Non c’è nulla di automatico in tutto questo: sono sistemi che richiedono comunque per essere perpetuati di investimenti e scelte in formazione, organizzazione e gestione. Sono i saperi dell’artigianato di qualità e dell’industria evoluta, ma sono anche i sapori della cucina, delle tradizioni agroalimentari. Sono “saperi” e competenze, che hanno bisogno di essere trasferiti nelle nuove generazioni, prima che queste si perdano in una indistinta omologazione globale, e che sono il riferimento per una strategia di attivazione che risponda all’identità italiana.
Negli ultimi anni la ripresa del Made in Italy di qualità ha contribuito a rilanciare il ruolo dei mestieri artigiani, ma soprattutto i valori culturali che sottendono alla dimensione artigiana dell’economia, anche quando si esprime attraverso una organizzazione di tipo industriale. La dimensione dell’artigianalità è pienamente culturale e quindi si esprime non solo nell’economia, ma anche nei legami sociali che determina. Dove si riducono i luoghi dell’apprendimento e della produzione artigianale, come accade in alcune periferie urbane ed in altri contesti italiani, si determina un aumento del disagio sociale, non solo di quello economico, perché viene indebolita la comunità nel suo insieme. Il tessuto sociale italiano ha ancora oggi a che vedere con il mantenimento del saper fare e delle competenze artigiane.
La prospettiva del Quarto capitalismo, il ruolo delle vocazioni territoriali, la dimensione qualitativa dell’economia ed il rapporto tra tradizione e innovazione costitutivo dello stile italiano possono offrire importanti prospettive per l’artigianalità italiana e declinare quello che alcuni validi studiosi definiscono come “futuro artigiano”. Potenziare la formazione, collegarsi con le scuole, gli istituti tecnici, gli ITS e le Università, legare l’autoimpiego alle politiche attive, diffondere gli strumenti di agevolazione all’avviamento ed aggiornare la legge nazionale sull’impresa artigiana sono tutti elementi di una strategia di intervento per la promozione dell’avviamento di imprese artigiane che è utile all’economia, ma anche alla società italiana.
In questo senso un’ulteriore sfida è rappresentata dalla transizione demografica in Italia. Bilanciare il bisogno di inclusione dei giovani nell’imprenditorialità, in linea con le sfide poste dalla transizione demografica, richiede un approccio strategico e integrato.
Una strategia complessiva ed integrata per la promozione dell’imprenditorialità, soprattutto se artigiana richiede misure volte a:
sviluppare programmi educativi attrattivi per i giovani imprenditori, fornendo loro le competenze necessarie per avviare e gestire nuove iniziative;
implementare percorsi di formazione continua per le fasce d’età più mature, per consentire loro di aggiornare le proprie competenze e adattarsi ai cambiamenti;
dedicare programmi specifici per adeguare le conoscenze e le competenze degli over 50, spesso bisognosi di percorsi di reskilling, così come per i senior in uscita dai contesti di lavoro dipendente intenzionati ad avviare attività imprenditoriali (o professionali), forti di esperienze e conoscenze specialistiche, attraverso percorsi di up-skilling;
adottare e sostenere pratiche di imprenditorialità intergenerazionale, in grado di incoraggiare il mentoring tra giovani e imprenditori più esperti, non solo per facilitare il trasferimento di conoscenze, ma anche per favorire ambienti collaborativi in cui le diverse esperienze possano integrarsi per sviluppare progetti innovativi. favorire il passaggio intergenerazionale, affrontando gli ostacoli caratterizzati da barriere culturali e burocratiche;
rafforzare le start-up innovative, attraverso politiche pubbliche che ne facilitino l’accesso al mercato e all’innovazione tecnologica.
SOCIAL
CONTATTACI
INDIRIZZO
SOCIAL
Via Nizza, 53 – 00198, Roma
Via Nomentana, 56 - 00161 Roma
© copyright 2023 | C.F. 96568340580 | All Rights Reserved.
L’ARTIGIANALITÀ ALLA BASE DELLA CULTURA DEL LAVORO ITALIANO
L’ARTIGIANALITÀ ALLA BASE DELLA CULTURA DEL LAVORO ITALIANO
2025-04-24 15:29
2025-04-24 15:29
Array( [86865] => Array ( [author_name] => Emidio SIlenzi [author_description] => [slug] => emidio-silenzi ) [87630] => Array ( [author_name] => Andrea Striano [author_description] => [slug] => andrea-striano )) no author 86807
lavoro, lavoro, artigiani, start-up,

di Romano Benini

L’AUMENTO DELL’OCCUPAZIONE E GLI EFFETTI SU CRESCITA, WELFARE E SVILUPPO
di Romano Benini
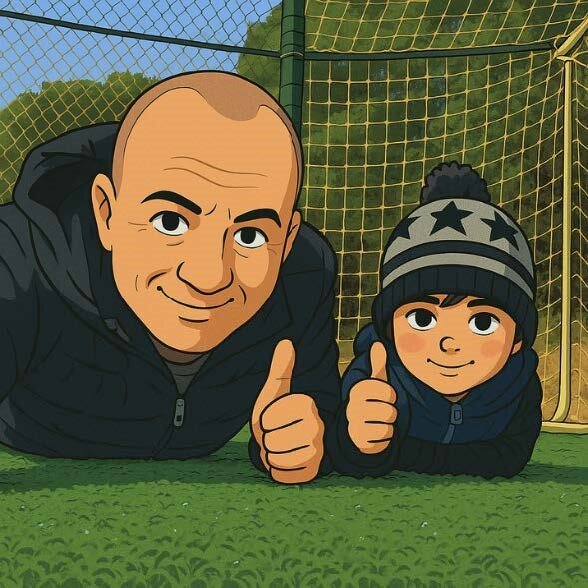
DOPPIA VISIONE - MARE, MONTAGNA E TEMPO LIBERO: il segreto dell’equilibrio tra lavoro e vita privata
DOPPIA VISIONE - MARE, MONTAGNA E TEMPO LIBERO: il segreto dell’equilibrio tra lavoro e vita privata
di Pietro Vivone & Filippo

LINGUE STRANIERE E MONDO DEL LAVORO: conoscerle incrementa le performance?

