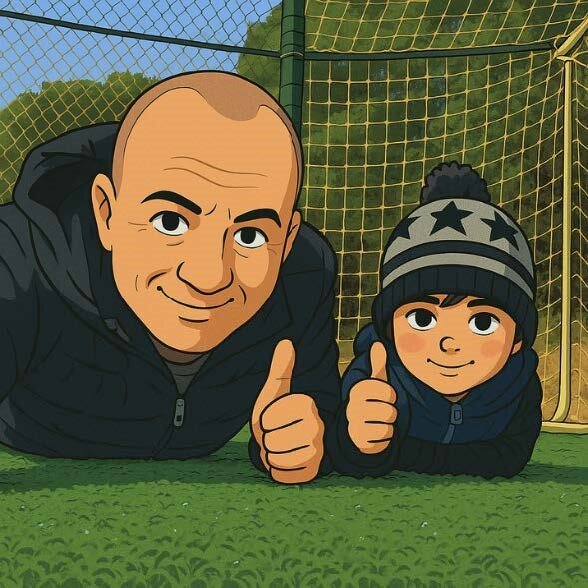di Romano Benini
L’aumento dell’occupazione italiana
In un contesto globale di crescita economica limitata, soprattutto in Occidente ed in Europa, negli ultimi tre anni l’Italia ha avuto una significativa crescita dell’occupazione, che va considerata e valutata insieme alla crescita ancora maggiore che è intervenuta della domanda di profili professionali da parte delle imprese.
Sono diversi i fattori che motivano questa spinta alle assunzioni, che ha contribuito a ridurre in modo molto significativo il tasso di disoccupazione italiano, tra cui l’aumento della domanda di competenze, la ripresa degli investimenti in alcuni settori e l’esigenza di un ricambio, anche generazionale, della forza lavoro.
L’aumento quantitativo degli occupati ha determinato una ripercussione su alcuni aspetti della qualità della condizione lavorativa ed ha contribuito a determinare significativi effetti sulla tenuta sociale, sulla crescita e sul controllo della spesa e dei conti pubblici. Rispetto al mese di settembre 2022, se valutiamo i dati disponibili a giugno 2025 (Istat, dati destagionalizzati), si registrano a livello nazionale i seguenti fenomeni che riguardano le dinamiche del mercato del lavoro:
Un mercato del lavoro più dinamico e con maggiori opportunità può portare a un miglioramento del benessere sociale, con meno tensioni dovute alla disoccupazione. Il calo del ricorso alla CIG in deroga, ormai residuale, in particolare mostra un generale miglioramento delle condizioni economiche, che riduce la conflittualità sociale e sostiene la fiducia di imprese e lavoratori.
Gli effetti positivi
Questi fenomeni si accompagnano a conseguenze positive sulle condizioni del lavoro e sociali ed è utile segnalate alcuni tra questi effetti che hanno un diretto impatto sui fattori determinanti per la crescita e lo sviluppo (differenza tra settembre 2022 e marzo 2025):
L’aumento dell’occupazione in Italia sta favorendo alcuni effetti positivi sull’economia e sulle condizioni per lo sviluppo, aumentando la spesa dei consumatori grazie all’aumento del monte salariale ed innescando un circolo virtuoso che supporta la crescita aggregata (Pil), determinando un maggiore controllo ed equilibrio dei conti pubblici, della spesa previdenziale e del gettito fiscale.
L’andamento quantitativo e qualitativo del mercato del lavoro contribuisce a determinare queste conseguenze, registrate tra la seconda metà del 2022 ed il primo trimestre 2025:
Questi effetti hanno permesso il contenimento del costo del sistema e della spesa previdenziale (aumento del gettito contributivo e diminuzione della Naspi) e degli effetti dell’andamento demografico sulla spesa pubblica (effetto combinato).